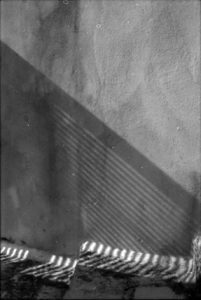
L’aveva accolto con un sorriso largo, bianchissimo, al di sopra del quale le due grandi iridi verdi si increspavano come l’acqua dei laghi: “Il dottore la riceverà fra un istante. Intanto perché non si accomoda? Si metta pure a suo agio: sarà senz’altro questione di pochi minuti”. Il fascio di fogli sciolti le premeva contro il seno, e Luigi si sorprese a fantasticare sul tipo di sostegno che aveva scelto di indossare quella mattina. Il leggero chiarore che traspariva dalla trama della maglia accollata, altrimenti nera, lo disponeva favorevolmente verso un reggiseno di colore bianco. Ma se in pizzo o elasticizzato questo non era in grado di stabilirlo. Crema comunque no: una come lei non avrebbe mai ceduto a una tale pacchiana mancanza di senso estetico: aveva una pelle troppo chiara e un’evidente propensione alla malizia compiaciuta per rinunciare alla sensualità che scaturisce dal contrasto dei toni. Tanto valeva non portarne affatto, ma questa era naturalmente tutta un’altra faccenda.
La stanza dava su un cortile interno inquadrato da una finestra alta e piuttosto stretta. Il davanzale arrivava a malapena alle anche. Si sarebbe potuto dire che l’architetto responsabile dell’opera, nonostante la marsina e la cravatta a fiocco, avesse avuto una predilezione per le vertigini del gotico. Forse più semplicemente l’aveva per le smanie degli aspiranti suicidi.
In effetti, schiantandosi sul selciato, il corpo di un angelo avrebbe conferito alla scena un elemento di completezza di cui, attualmente, era manifestatamente priva. Il cortile aveva la forma di un settore circolare. Sull’arco interno si apriva la finestra dalla quale uscivano a folate le fantasticherie di Luigi mentre su quello esterno, più ampio, una serie di finestrelle e balconcini con le righiere in ferro battuto faceva da quinta; al centro, una fontana a tre piani decrescenti priva di zampillo sgrondava acqua dal tappeto di muschio che arrivava a lambire i bordi delle vasche. Cerchi metodici si allargavano sulle superfici ad ogni goccia; solo nell’ultima vasca, di tanto in tanto, l’ordine stabilito delle cose si concedeva una tregua e scie pigre si muovevano autonomamente in senso antiorario. Pesci rossi, probabilmente.
Ecco, lanciandosi di là, l’assenza quasi totale di propulsione e un’altezza tutto sommato modesta – appena due piani – avrebbe donato al cadavere una postura aggraziata, smisuratamente elegante: il capo reclinato racchiuso dalle braccia allargate, il ginocchio della gamba sinistra ad angolo retto rispetto al torso, la destra allungata e morbida. Nessuna frattura evidente: solo un rivolo cremisi avrebbe attestato senza dubbio alcuno la presenza della morte. Un filo appena dal naso e dalla bocca, un’eiaculazione insolentemente tardiva nell’ultimo amplesso con la durezza della vita.
A Luigi quella fontana e quell’aria sospesa ricordavano un’altra fontana e un’altra atmosfera. C’erano anche i pesci rossi, ma era tutto diverso. Aveva nove anni, allora, e alla morte non pensava affatto: aveva il vento sulla faccia e sudore lungo il collo e gambe che pompavano velocità stratosferiche; c’era una solitudine ovattata e felice, i pini che svettavano alti su Villa Celimontana, l’aria calda assordante di cicale, e sopra ogni cosa, irrangiungibile come una dea, c’era un’Aquiletta blu lanciata come un proiettile lungo la pista polverosa del parco giochi.
Alle pareti non era appeso nulla. Bianco immacolato come un sudario. Bianco anche il mobile basso che correva tutt’intorno. In un angolo, il proiettore dei lucidi, due televisori, un computer e un lettore video. Sarà per le presentazioni dei nuovi prodotti alla forza vendita, argomentò Luigi. Magari fra una settimana ci sarebbe stato anche lui intorno al tavolo delle riunioni a prendere appunti sulle quote di mercato, le curve di vendita e le previsioni di fatturato. Certo che sarebbe andata così! E lui avrebbe annuito di tanto in tanto per sottolineare il rigore espositivo del suo direttore, gli occhi ancorati allo schermo delle proiezioni. Davanti i fogli sparsi della documentazione, fra i denti schegge di legno morbido strappate al lapis dalla forza della concentrazione.
Si avvicinò al tavolo sfiorandone la superficie con le dita tese, tirò indietro una sedia di metallo rivestita in pelle nera e vi si appoggiò stancamente. Le tre.
Era arrivato in città due ore prima ma aveva fatto in modo di farsi annunciare dalla ragazza della reception solo a pochi minuti dall’appuntamento. Sapeva il fatto suo, non c’erano dubbi su questo: mai in ritardo ma mai nemmeno con troppo anticipo. Il giusto, ecco: era la regola. Doveva sembrare un amabile e disinteressato scambio di opinioni fra persone alla pari, mica una petizione o peggio ancora una spaurita richiesta di estremo soccorso.
Merda! Ma che cazzo ne sapevano loro di quanto significasse per lui avere quel fottutissimo posto! Le cambiali si accumulavano inevase da almeno due mesi nel piatto decorato al centro del tavolo in soggiorno; non aveva ancora pagato le ultime due rate del mutuo e per quanto riguardava l’auto gli avevano già comunicato a quanto ammontavano gli interessi per ritardato pagamento.
Un sudore diaccio prese a velargli le palme delle mani. Doveva rimanere calmo. Calmo, cazzo, e rilassato.
Calmati Luigi, – si ripeteva, – calmati.
Rigore, ci voleva, ecco cosa. Un sottile quanto effimero equilibrio tracciato nel solco dell’orologio, una piroetta sentita per quanto artificiale sufficiente a cadere a piedi uniti e dire “Eccomi. Mi chiamo Tal dei Tali, molto piacere davvero”. Chi aveva deciso per un’interpretazione fuori copione era stato il tempo mutevole di quell’assurda città.
Luigi guardò sconsolato la mappa di continenti disegnata sul suo trench color sabbia. Fradicio. Quando era sceso alla Stazione Centrale non pioveva, ma era piovuto per tutto il giorno precedente e per quello prima. Tuttavia, quando era uscito sul piazzale della stazione, il cielo basso e lattiginoso gli aveva fatto capire che quella era solo una tregua fragile e transitoria concordata col fluttuare incessante e imprevedibile del caso. Inafferrabile come lo stronzo al volante di un taxi distratto che lo aveva inondato di fanghiglia e acqua nera di smog mentre stava per decidere se prendere un taxi o affidarsi alla proverbiale efficienza che lì veniva pacificamente accordata al mezzo pubblico.
Il risultato, comunque, era del tutto inoppugnabile: chiazze scure e irregolari si allargavano sul tessuto stazzonato del gabardine.
L’ambiente era troppo neutro, asettico e soffocante per adeguarsi alle mutazioni, così Luigi fumava denso come uno scappamento rotto e gli sbuffi lievi della normalizzazione termica gli donavano un’aura quasi sacrale. L’umore però non aveva nulla in comune con l’esaltazione ieratica dei martiri. Era piuttosto come uno di quei cavalli lenti che davanti ai cancelli del macello, d’inverno, cominciano a riconoscere nell’aria satura di nebbia l’odore del sangue e degli escrementi. Il puzzo acre e dolciastro della paura.
A dispetto della vertigine di cui si sentiva preda inerme, l’abbassarsi della maniglia non lo trovò impreparato: occhi verdi inquadrò Luigi in piedi, appoggiato con fare noncurante a un lato della finestra.
“Mi dispiace proprio, sono costernata. La telefonata sta durando più del previsto, ma vedrà: la riceverà presto. Lo gradisce un caffè?”
Luigi sorrise di rimando a un sorriso che sembrava sincero: nemmeno per un istante aveva dubitato che la riga sofferta che le arcuava le sopracciglia fosse meno che autentica. Occhi verdi peraltro non aveva varcato completamente la soglia, si era limitata soltanto a sporgere con il busto e Luigi si compiacque di riconoscere nel fatto un segno ulteriore della sua efficienza. Discreta ed efficiente, ecco, com’era; anche simpatica. E molto carina. “Grazie, sì.”
La porta si richiuse senza alterigia, come un rutto soffocato, e Luigi riprese a seguire il peregrinare assorto dei suoi pensieri.
Star lì era una deroga, un atto deliberato di parricidio impiegatizio, perché nella realtà il suo anziano datore di lavoro lo sapeva al nord per un improrogabile ciclo di visite mediche. Un tour che aveva poco o niente a che fare con la settimana premio a Sharm-el-Sheik che la ditta concorrente offriva ai suoi più meritevoli collaboratori, si era premurato di precisare Luigi con una punta di risentimento. Nonostante questo si sentiva a disagio: da come la vedeva lui era pur sempre un tradimento, forse ad essere indulgenti solo una marachella di poca importanza. Forse. Gli venne in mente, allora, un fatto analogo, un episodio che gli sembrava avrebbe gettato una luce di giustizia sull’intera faccenda. Da quello, infatti, avrebbe tratta una sentenza definitiva e inappellabile sulla cosa.
Gettò uno sguardo assorto alla fontana dei pesci rossi e, sì, le premesse c’erano tutte, si disse: coincidenze di lessico e colori deponevano favorevolmente alla risoluzione del caso, anzi: di entrambi.
La latteria era all’angolo del vicolo angusto, buio e dissestato che si inerpicava sofferto in direzione della via principale. Tutto era bianco lì dentro, persino le maioliche dietro il bancone, persino il faccione del lattaio sospeso in cima a un collo troppo largo e corto per indurre qualcuno a prendere il coraggio a due mani e strangolarlo per tale evidente assenza di dubbi. Un enorme frigorifero occupava quasi interamente la parete. Maniglie grandi e asettiche di acciaio celavano loculi al cui interno stazionavano confezioni diverse di latte in quieta ibernazione. I nomi risaltavano ancora vividi nei ricordi di Luigi, accesi come neon: Torre in Pietra, Centrale del Latte, Fattoria Latte Sano. Sua madre del latte della Centrale non si fidava affatto, per cui la scelta ricadeva sulla piramide verde prato di Latte Sano. Certo, era una confezione per niente pratica, però il fatto di essere così le conferiva un certo fascino. Del resto, a ben vedere, era l’unico packaging dichiaratamente e praticamente democratico: al mattino potevi regolare il flusso del versato secondo i tuoi bisogni o la fretta che ti attanagliava le viscere: dipendeva da chi eri. Un impiegato legato agli orari del filobus tagliava la punta della piramide in modo da ottenere un foro triangolare piuttosto ampio. Per te, invece, le forbici agivano più in alto. Un minuscolo opercolo dal quale il latte usciva sottile e aggrovigliato come un filo ritorto per scatenare una sottile linea di schiuma sul nero seppia del caffè d’orzo.
“Ecco qui. Le ho portato anche un bricco di latte fresco se lo preferisce macchiato.”
Accidenti, stavolta non l’aveva proprio sentita arrivare. Sul piano del tavolo riunioni si era materializzato un vassoio in bambù sul quale troneggiavano insolenti le porcellane spesse e fumanti. Bianche ogni oltre dire, ovviamente. Sopra di esse, saettavano divertite le iridi verdi di Francesca Tirelli, segretaria particolare di Edoardo Melandri, gran capo della Covex Italia, l’uomo che forse avrebbe potuto cambiare la sua vita.
“Si sta annoiando, vero? La capisco, non so dirle quanto mi dispiace. Un cucchiaino? due?”. “Uno raso, grazie, ma non deve disturbarsi…”.
“Non lo dica neanche per scherzo, è davvero il minimo che posso fare. Purtroppo il dottor Melandri è in video-conferenza con la sede di Londra.” Luigi annuì, lei si produsse in un sorriso angolato.
Di nuovo solo, e ormai, fuori, la bruma della sera aveva invaso ogni andito.
Sul bancone della latteria troneggiavano due grandi bocce di vetro. Luigi le ricordava bene. A destra, alta e cilindrica, c’era quella delle uova; accanto i fogli di giornale che servivano per incartarle in file di tre o cinque. Mai in numero pari, però, anche se il conto finale pari lo era sempre, decine o dozzine che fossero. Come nei mazzi di rose degli innamorati. Luigi ci si perdeva quasi sempre a contarle quelle uova, ma per quanto adottasse ogni volta una strategia diversa, mai che fosse riuscito una volta a terminare l’operazione. Magari non ci fosse stata l’altra boccia, quella panciuta delle pesche, forse sì, anche se non gli pareva cosa certa. D’altronde i fallimenti sembrano più lievi se gli si trova una scusa valida, e quei colori tenui – i rosa, gli azzurri, i verdini, i violetti, i paglierini – gli involti rigidi con stampato su il cerchio grigio che racchiudeva il prezzo del mistero (cinque o forse dieci lire, ora non ricordava esattamente), la bocca del vaso larga e invitante, erano una vera istigazione, altro che storie. E poi lui aveva solo nove anni. La boccia delle pesche stava sull’altro lato del bancone. Di solito, se tua madre lo aveva previsto, una pesca era il resto che ti toccava dopo aver pagato un litro di latte: il minimo sindacale che ti veniva riconosciuto per avere assolto l’incarico. Ma così non c’era gusto: potevi scegliere la pesca che ti pareva più promettente, avevi il tempo di soppesarne il contenuto, valutavi, ponderavi. Potevi starci anche mezz’ora. E per cosa poi? In fondo le pesche erano vere stronzate: rotolini di cartone grezzo coperti di carta colorata che al massimo contenevano un brutto soldatino di plastica, una macchinina, due biglie di vetro, un anellino. Paccottiglia, insomma. Il gusto vero era rubarle, non comprarle, e Luigi in questo era uno specialista. Appena il collo taurino del lattaio si torceva per aprire il frigo e prendere il litro, la sinistra di Luigi si tuffava rapida come un martin pescatore e silenziosa come il volo di un barbagianni sull’involto che aveva scelto, e mentre questa metteva al sicuro la preda nella tasca dei calzoni la destra già si protendeva molle e tenera con le monete. Mai guardare quello che si faceva: gli occhi dovevano rimanere infissi sulla nuca del grassone. Neutri e infantili, svagati quasi, anche se dentro l’eccitazione diventava incontenibile e ti piegava le gambe e ti faceva sudare le mani e i capelli a spazzola si rizzavano e il cuore batteva forte e tutto, intorno, cominciava vorticosamente a girare e girare e ti faceva avvampare la faccia mentre il tuo cervello cominciava a dirti: Ecco, si gira, m’ha visto, mi scopre, no, ti prego, per favore, per piacere, per piacere non ancora, ancora no. Quant’è? domandavi alla fine con la voce rauca come quando avevi la febbre. Come non lo sapessi, piccolo teppistello troppo perbene per esserlo davvero. Ma intanto quel piccolo tesoro era al sicuro e sapevi che il petto avrebbe cominciato a rallentare solo svoltato l’angolo, sul gradino del seminterrato del cartonaio, dove scoprivi finalmente l’oggetto da mille e una notte che il fato ti aveva destinato: la spada degli immortali, una lucente astronave, le sfere del popolo delle fate, il gioiello di una principessa. Una cosa così non potevi comprarla, non funzionava. Era una magia buona e andò avanti a lungo finché, una sera, lui si voltò davvero.
“Be’? E lei cosa fa qui?”
A Luigi il cuore fece una piroetta, un’ondata di gelo gli calò pirata su tutto il corpo e quella strana stanza bianca prese davvero le forme della latteria dei suoi incubi.
“Gli uffici sono chiusi. È tardi…”
Ci mise un poco a mettere a fuoco la figura corpulenta di una signora in camice celeste che lo guardava preoccupata. “Mi spiace, non volevo spaventarla, ma dovrei riordinare … Gli uffici sono chiusi” ripeté.
Luigi riuscì solo a farfugliare un “Si figuri, scusi lei, ero soprappensiero. Ma che ore sono?”, prima di accorgersi da quello che vedeva fuori che dovevano essere almeno le otto.
“Non capisco. Mi avevano detto di attendere… Avevo un appuntamento…” e per dimostrare la veridicità di quanto andava balbettando, Luigi indicò il vassoio sul tavolo con la tazzina e tutto il resto. La donna delle pulizie scosse la testa. “Venga, l’accompagno di sotto, altrimenti il vigilante all’ingresso non la lascia andare.”
Nell’ascensore, uno di fianco all’altra, non dissero nulla ma si vedeva che in lei il lato materno aveva preso il sopravvento. Lo guardava di sotto in su cercando le parole per consolarlo, ma a Luigi, piantato davanti alle scorrevoli, non veniva neanche da piangere. Era solo stanco, infinitamente stanco. Voleva solo consegnarsi definitivamente alla notte.
”Grazie. E mi scusi tanto” disse Luigi alle due mani rovinate dai detersivi poggiate sull’asta della scopa.
“Senta…”
“Sì?”
“Non si preoccupi. So come vanno certe cose. Vedrà, le faranno sapere.”
“Già. Grazie. Buona notte.”
“Buona notte.”